"L'AI non ruba il lavoro, lo ruba la mediocrità": Simone Enea Riccò e "La Verità Algoritmica"
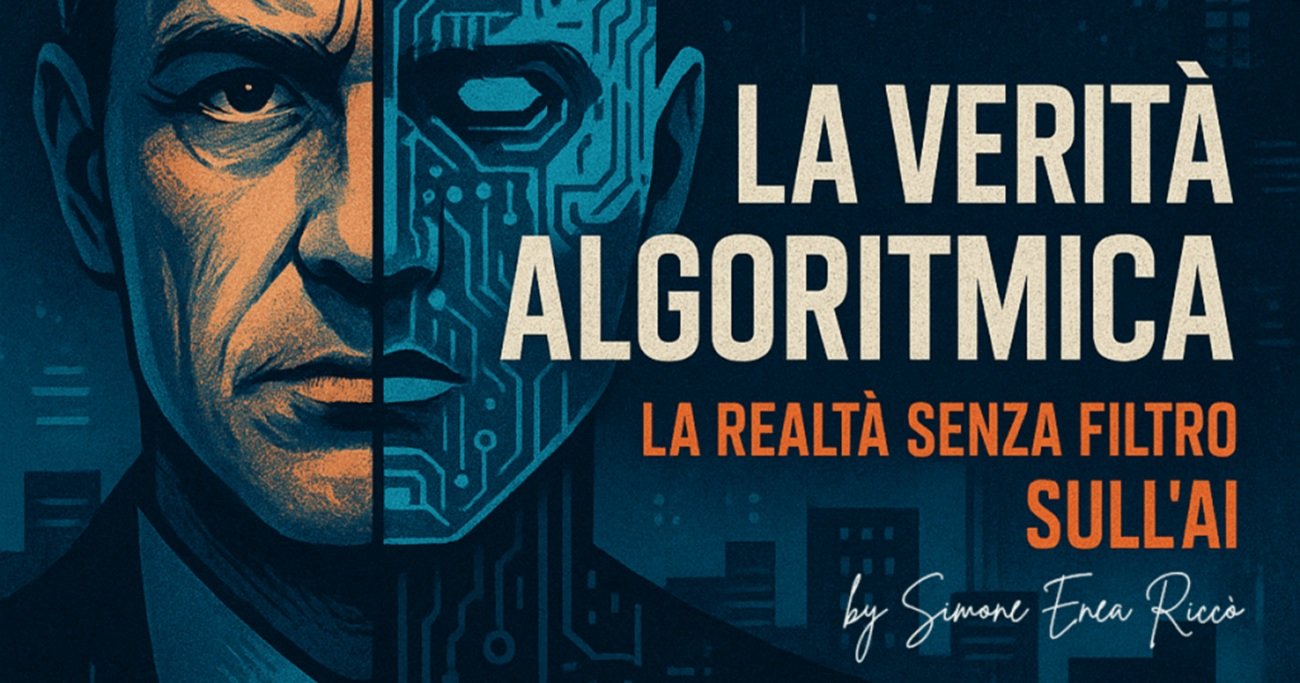
Simone Enea Riccò non è il tipo che si fa abbagliare dalle mode tecnologiche. Con oltre quindici anni di esperienza ai vertici del marketing e della strategia digitale, ha visto passare molte rivoluzioni annunciate e poche realizzate. Eppure l'intelligenza artificiale, per lui, è diversa. Non perché sia l'ennesima buzzword da inserire nelle presentazioni aziendali, ma perché sta davvero cambiando il modo in cui le aziende possono comprendere e anticipare i bisogni dei loro clienti.
Marketing Director e AI Strategy Leader, Riccò è il founder de La Verità Algoritmica, un osservatorio e podcast che esplora l'impatto reale dell'AI nel business, nella comunicazione e nella società. La sua missione dichiarata è demistificare l'intelligenza artificiale, renderla accessibile, andare oltre l'hype tecnologico per arrivare a quella che lui definisce "innovazione consapevole e umano-centrica". Nel suo curriculum spiccano strategie di marketing e rebranding per brand internazionali, programmi di loyalty ripensati per leader del settore, e collaborazioni con istituzioni del calibro del Parlamento Europeo ed Expo 2015. Un percorso che gli è valso, tra gli altri riconoscimenti, l'NC Awards 2019 per la migliore campagna di relazioni pubbliche in Italia.
Autore di due libri che cristallizzano la sua filosofia, "Marketing AI: La Guida Strategica" e il romanzo di business "L'AI mi ha rubato il lavoro" in uscita il 28 novembre, Riccò costruisce ponti tra il potenziale teorico dell'AI e i risultati di business tangibili. E quando gli chiedo di quelle applicazioni concrete, quelle che producono ritorno sull'investimento misurabile e non sono semplice fumo negli occhi, la sua risposta è chirurgica.
Dal megafono alla predizione: l'evoluzione del marketing
"Le aziende che si stanno davvero interrogando sull'AI si chiedono: 'Ok, ma l'AI a cosa serve? Dove la uso? Perché la uso? Quali problemi voglio risolvere?', sono principalmente due le aree: la tecnologia e il marketing", spiega Riccò. Il motivo è semplice: il marketing aveva già nella sua cassetta degli attrezzi l'automazione, i funnel, l'analisi del customer journey. Il salto evolutivo dell'AI non è stato quindi traumatico, ma quasi naturale. "Fino a ieri eri reattivo, pensavi al consumatore. Adesso pensi al consumatore in un'ottica predittiva".
Ed è proprio sulla predizione che si concentrano le applicazioni più mature. Se riesci a classificare i consumatori in maniera efficiente grazie ai dati, oggi puoi fare scoring del singolo cliente o prospect e ragionare in termini di valore predittivo. Il Customer Lifetime Value predittivo, ad esempio, permette di calcolare in proiezione quale cliente ha maggiori potenzialità e merita quindi maggiori investimenti rispetto a un altro che storicamente risponde a pattern meno interessanti. Un cambio di paradigma che trasforma il budget marketing da spesa distribuita a caso a investimento mirato.
Ma la vera miniera d'oro, secondo Riccò, sta nella predizione del churn, l'abbandono del cliente. "La loyalty e la retention del cliente sono super importanti. È fondamentale intercettare i segnali che indicano che un cliente è in odor di churn, segnali che prima non si vedevano all'interno del data lake". Recuperare un cliente che sta per abbandonare costa infinitamente meno che acquisirne uno nuovo, e qui l'AI fa la differenza tra vedere il pattern e perderlo nel rumore di fondo.
Tutto questo porta a un ripensamento radicale del marketing stesso. Via il marketing del megafono, quello che urlava più forte della concorrenza provocando interruzione su interruzione. "In un'economia basata sulla fiducia come quella europea", dice Riccò riferendosi a un modello diverso dalla potenza dell'AI americana e cinese, "l'interruzione stufa l'utente. La quarantesima mail di un brand non è comunicazione, è spam". L'alternativa è fornire valore e contesto, capire grazie alla predizione algoritmica cosa vuole ricevere l'utente in modo che la comunicazione non sia un'interruzione ma un servizio. La mail che suggerisce attività in Sicilia dopo che hai prenotato un volo non è invasiva, è utile. E questa è la differenza tra marketing reattivo e marketing predittivo.
L'istinto contro i dati: perché i progetti AI falliscono
Il libro "Marketing AI: La Guida Strategica" è nato da una constatazione amara. "Vedevo molte aziende prese dalla moda del 'facciamo l'investimento'", racconta Riccò. "La decisione d'istinto era comprare il tool, comprare l'AI, fare mega progetti, spendere soldi, e poi sei mesi dopo i report mostravano che i progetti AI fallivano al 75%, 85%, un miliardo di percento". È il tema delle decisioni prese d'istinto, guidate dal flavor del momento, dal bisogno di fare qualcosa alla moda. E finiscono male, quasi sempre.
L'errore più comune? Non chiedersi com'è il proprio data lake. Se il dato è sporco, la predizione sarà sbagliata. È il principio del "garbage in, garbage out" che nell'AI diventa ancora più spietato. Progetti ambiziosi di CLV predittivo o churn rate predittivo che falliscono miseramente perché si fa uno scoring malissimo, magari senza aver mai fatto un lavoro di pulizia del dato, o peggio ancora senza avere nemmeno un CRM decente. "Ho scritto una bussola strategica che non fa perdere la gente in cose d'istinto, ma dà un pattern, un framework, uno schema da seguire, per farsi le domande giuste", spiega.
E poi c'è l'effetto FOMO, la Fear of Missing Out, la paura di rimanere fuori dai giochi. Si cerca di fare qualcosa d'istinto, ci si butta. La raccomandazione di Riccò è netta: tentare e provare, ma con proof of concept piccoli e test. "Non si deve fare l'investimento da cinquecento milioni di euro senza aver prima testato se il progetto era scalabile e se si avevano i dati in azienda per raggiungere l'obiettivo".
Il problema di fondo, però, è più profondo ed è emerso in tutti i report sullo stato dell'AI aziendale: manca la competenza. Non c'è AI literacy, la formazione è insufficiente nonostante sia diventata obbligatoria nell'AI Act europeo. Le aziende non hanno ancora cominciato a investire seriamente nel reskilling. E le persone che vogliono veramente cambiare e crescere professionalmente si stanno muovendo autonomamente, iscrivendosi a master per l'empowerment della loro professione.
L'intelligenza emotiva che l'algoritmo non ha
"L'AI mi ha rubato il lavoro, storia di un manager mediocre" è il titolo provocatorio del romanzo in uscita il 28 novembre. Riccò affronta il tema di un manager che non dà la colpa alla sua mediocrità, ma alla tecnologia. "La vera minaccia non è la tecnologia, ma la mediocrità", sintetizza. Ed è qui che entra in gioco il tema delle competenze del futuro, quelle che nessun algoritmo potrà sostituire.
Le persone devono allenare il reasoning, il ragionamento critico. Il reskilling non può limitarsi a corsi di prompting, per quanto utili. Servono competenze più profonde: il pensiero critico e l'intelligenza emotiva. Riccò cita un esempio che fa riflettere: il dilemma del tram sottoposto a Gemini, l'AI di Google. Di fronte alla scelta tra investire due milioni di bambini o il Presidente degli Stati Uniti, l'algoritmo ha scelto di sacrificare i due milioni di bambini. "Non ha l'addestramento e l'intelligenza emotiva per prevedere le conseguenze emotive e sociali: l'instabilità politica, la rivolta contro le macchine".
La macchina non fa questo ragionamento emotivo perché non può farlo. Calcola, ottimizza, predice, ma non comprende il tessuto sociale, le implicazioni morali, il peso di certe scelte. Per questo, secondo Riccò, la formazione deve premiare corsi che diano competenza tecnica ma anche intelligenza emotiva e pensiero critico. Non basta sapere come usare l'AI, bisogna sapere quando non usarla.
Quando il reskilling diventa una corsa contro il tempo
Le rivoluzioni storiche del lavoro, quella agricola e quella industriale, sono avvenute nell'arco di decenni o addirittura secoli. Questa è diversa, molto più veloce. "È un po' difficile", ammette Riccò quando gli chiediamo come gestire una richiesta di reskilling così rapida e violenta. Il problema riguarda soprattutto le persone che fanno un lavoro ripetitivo da vent'anni, che non hanno l'abitudine a rimettersi in gioco, a studiare.
Non tutto è per tutti, e fino a lì è chiaro. Ma chi ha voglia di evolversi, forse è il caso di cominciare ora. Riccò non crede che dopodomani scoppierà il mondo e le persone perderanno tutto il lavoro per colpa dell'intelligenza artificiale. Come in tutti i cambiamenti nella storia, però, chi vuole sopravvivere deve muoversi. Il punto di partenza in Italia è complicato: c'è un analfabetismo digitale riconosciuto anche dal Ministero, una base fragile su cui costruire la trasformazione.
Le preoccupazioni maggiori, faccio notare, riguardano chi lavora in settori dove c'è manualità pura o catena di montaggio. Quando una macchina sostituisce un lavoro manuale, ricollocare quella persona diventa estremamente difficile. E non parliamo solo di operai: anche il ragioniere cinquantenne che si occupa delle fatture, nonostante le sue capacità, si trova in difficoltà se viene sostituito da un software. Non può improvvisamente diventare un prompt engineer. Riccò conferma: "Una professione completamente manuale e replicabile diventerà una commodity".
Nel libro in uscita, Riccò affronta il tema del "manager calcolatrice" che si è affidato all'AI senza interrogarsi, rendendosi sostituibile. L'obiettivo, a vari livelli e con competenze differenti, è rendersi insostituibili. Un obiettivo che diventa sempre più urgente se si pensa che nel 2030 la robotica costerà sui ventimila euro e sarà molto più diffusa di oggi.
L'uomo al centro, anche quando decide l'algoritmo
Quando si parla di etica nell'AI, il tema della Black Box diventa centrale. "L'explainability dell'AI diventa super chiave", sottolinea Riccò. Uomo al centro significa che l'uomo è il decisore finale. Tornando all'esempio del dilemma del tram, chi deve tirare la leva, informato dai dati dell'AI, è l'essere umano, non la macchina.
A livello etico, certe decisioni devono essere prese con una responsabilità umana. L'AI fa i calcoli, dà la predizione e l'informazione, ma deve anche spiegare il reasoning che c'è stato dietro, quello che spesso non si vede. Solo dopo essere stato informato in modo trasparente, l'uomo prende la decisione. Questo è il concetto di "uomo al centro" e delle humanics, la disciplina che studia l'interazione tra capacità umane e tecnologia.
Per un'azienda, questo significa che l'innovazione AI deve essere percepita come umano-centrica per trasformare la fiducia del cliente nel principale vantaggio competitivo. In un contesto digitale in continua evoluzione, la brand reputation si costruisce sulla trasparenza degli algoritmi utilizzati e sulla garanzia che dietro ogni decisione importante ci sia un essere umano responsabile.
Umani che parlano a macchine che parlano agli umani
Il paradigma sta cambiando velocemente. "Se oggi vuoi scegliere tra Apple e Samsung, non vai più su Google, chiedi a Gemini o ChatGPT", osserva Riccò. È un cambio radicale nel modo in cui le persone cercano informazioni e prendono decisioni d'acquisto. E questo significa che i brand devono ripensare completamente la loro presenza digitale.
Bisogna essere rilevanti per l'algoritmo affinché la sintesi data dall'algoritmo, quella che arriva all'umano, sia interessante e corretta. L'interlocutore non è più l'umano direttamente, ma "siamo umani che parlano a macchine che parlano ad umani". Un po' come in quel gioco del telefono senza fili che facevamo da bambini, solo che qui il messaggio deve arrivare intatto.
Per questo motivo è necessario avere un ragionamento di brand olistico. Il brand deve curare le recensioni, mantenere un posizionamento coerente su tutti i canali, fare una SEO pensata affinché l'algoritmo consideri affidabile ciò che dice. L'obiettivo è far sì che l'algoritmo legga correttamente il sito, le recensioni, i siti di terzi, i competitor e gli aggregatori, e ne faccia una sintesi corretta rispetto a come l'azienda vuole apparire. Solo così la persona che legge quella sintesi potrà prendere una decisione informata.
Non è più una questione di engagement fine a se stesso, di visibilità a tutti i costi. È una questione di autorevolezza agli occhi dell'algoritmo, che poi diventa autorevolezza agli occhi delle persone. Un marketing a due livelli, dove il primo filtro non è umano ma artificiale.
Regolamentazione: il vero game changer dei prossimi cinque anni
Quando gli chiedo quale sarà la vera sfida che definirà il futuro dell'intelligenza artificiale nei prossimi cinque anni, se lo sviluppo tecnologico, la regolamentazione legislativa o la governance aziendale, Riccò non ha dubbi. "Siamo molto lontani dall'applicazione dell'AI Act ed è la cosa più importante oggi: avere una normativa efficiente ed etica che regolamenti l'applicazione".
Una fuga tecnica non è opportuna perché andrebbe poi smontata secondo la nuova regolamentazione. La governance aziendale si costruisce se ci sono le leggi, quindi le leggi sono la prima parte da cui partire. "La legge è la cosa più importante dalla quale inquadrare tutto il resto", spiega. Anche se purtroppo la pubblica amministrazione è troppo lenta su questi cambiamenti, la regolamentazione rimane la priorità assoluta.
È un approccio che riflette il modello europeo, quello dell'economia basata sulla fiducia di cui parlava prima. Mentre America e Cina corrono sulla potenza tecnologica pura, l'Europa prova a costruire un framework etico e legale che garantisca che l'innovazione sia sostenibile e umano-centrica. Un approccio più lento, forse, ma potenzialmente più solido nel lungo periodo.
La conversazione con Simone Enea Riccò lascia con una certezza: l'intelligenza artificiale non è il problema, e probabilmente nemmeno la soluzione. È uno strumento, potente quanto pericoloso se usato male. La vera differenza la fanno le persone: quelle che si formano, che sviluppano pensiero critico e intelligenza emotiva, che si pongono le domande giuste prima di investire milioni in progetti destinati a fallire. L'AI non ruba il lavoro a chi si rende indispensabile con competenze uniche. Lo ruba solo a chi era già sostituibile, a chi si nascondeva dietro la mediocrità di processi ripetitivi senza mai interrogarsi sul valore che portava.
Come dice Riccò, non è questione di essere pessimisti o ottimisti sul futuro. È questione di scegliere da che parte stare: dalla parte di chi subisce il cambiamento o dalla parte di chi lo guida. E questa, alla fine, è sempre stata una scelta personale.
